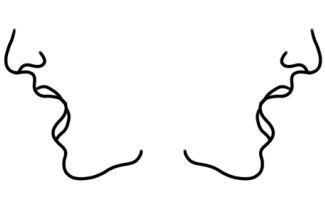Facciamo un breve riepilogo. Soltanto negli ultimi tre anni, tra le altre cose, si sono verificati eventi che delineano perfettamente i contorni di una crisi che è necessario affrontare con la consapevolezza che, probabilmente, siamo già troppo in là per arginare.
Il primo di questi in ordine cronologico è l’ondata di gelo che colpì il Midwest degli Stati Uniti a inizio 2019. Chi non ricorda le suggestive immagini del lago Michigan e delle Cascate del Niagara congelati, le colonnine di mercurio che segnavano temperature fino a 20°C sotto lo zero e quelle dei venti che raggiungevano picchi di -50°C. Per gli appassionati di cinema, quelle immagini non possono non aver ricordato la pellicola di Emmerich del 2004 The day after tomorrow. In quel caso i decessi causati dal gelo furono circa una ventina. Anche in quell’occasione, l’ex presidente USA Donal Trump non perse occasione per manifestare la sua più totale ignoranza – o, piuttosto, malafede – in fatto di clima, invocando il riscaldamento globale per arginare il Polar Vortex. Inutile dire che quel gelo inusuale fu una diretta conseguenza dell’innalzamento delle temperature globali. L’argomentazione di Trump fonda le sue basi su un errore piuttosto diffuso ossia quello di far coincidere il meteo locale di una determinata zona o regione con il clima nel suo complesso. In realtà, come confermano i climatologi, quel gelo improvviso nel Midwest fu causato dal cambiamento delle correnti artiche generato dall’innalzamento delle temperature globali.
Il secondo evento non può che essere la pandemia di COVID-19. Un virus, almeno stando all’opinione degli scienziati più autorevoli, compie il salto di specie, il cosiddetto spillover, e genera il caos in tutto il globo. Ad oggi, i decessi causati dal Sars-Cov-2 nel mondo sono più di quattro milioni, come se l’intera città di Los Angeles fosse stata spazzata via in appena un anno e mezzo.
Ultimo evento, ma solo in senso cronologico, è l’ondata di caldo torrido che ha colpito il Canada nelle scorse settimane, crisi che, a quanto dicono gli esperti, non è ancora finita, dato che ci si aspetta una nuova ondata nei giorni a venire. Le temperature medie in quella regione variano da zona a zona, dai 20°C delle coste ai 35°C di Toronto e Montreal. Quello che è successo recentemente ha dell’incredibile: picchi di 50°C, circa 700 vittime e una settantina di incendi ancora attivi su una superficie di quattromila chilometri quadrati.
Quindi: gelo artico negli States, pandemia e caldo infernale in Nord America, solo per citare alcuni degli eventi più in vista al grande pubblico. Secondo la narrazione dei media, essi sono figli del cambiamento climatico, cosa che, da un lato, dovrebbe consolarci visto che, fino a qualche tempo fa, il riconoscimento degli effetti di questo fenomeno non era poi così scontato. Ma se il parlarne apertamente è di certo un traguardo, è importante anche capire in quali termini se ne parla.
Ad esempio, una costante che emerge dai reportage giornalistici e dagli studi scientifici sul tema è l’attribuzione dell’innalzamento delle temperature globali a generiche “attività umane”. Per quanto sia fuori discussione che il dramma che affrontiamo e affronteremo ancora per molto non è certo imputabile ai pellicani o ai castori ma, ovviamente, al modello di vita sempre più invasivo della specie umana, un simile discorso rischia di non cogliere quelle che sono le cause reali del fenomeno e, quindi, di spoliticizzare la questione. Parlare di generiche “attività umane” come causa principe del cambiamento climatico sottintende un’equa spartizione delle responsabilità a tutti i 7,85 miliardi di individui umani che popolano la Terra. È più che mai logico, però, argomentare il contrario: la società umana non è una società equa, pertanto non può essere equa la spartizione delle responsabilità per quanto riguarda le cause della distruzione del nostro pianeta.
I popoli aborigeni dell’Australia, così come gli abitanti dell’Africa o, ancora, le fasce povere dei paesi del Sud America non possono essere responsabili dell’alterazione degli equilibri del nostro ecosistema. Essi, piuttosto, sono coloro che sono maggiormente esposti ai suoi esiti disastrosi. Non sarebbe del tutto corretto, però, farne una questione meramente geografica. Che responsabilità avrebbero le classi più disagiate del tanto progredito Occidente? È vero che c’è buona probabilità che un europeo povero abbia comunque più facile accesso ai servizi essenziali e, quindi, più chance di sopravvivenza rispetto, ad esempio, a un africano povero. Ma in questo vi sarebbe della compartecipazione al disastro ecologico al quale anche la produzione di quei beni e servizi essenziali, alla fine, partecipa? Pertanto, il primo importante assunto che dobbiamo tenere a mente è che le fasce povere di qualsiasi nazione, da Est a Ovest, da Nord a Sud, non possono essere accusate del graduale annientamento degli equilibri ecosistemici.
Veniamo allora alle classi medie, per quanto il concetto stesso di “classe media” abbracci uno spettro di redditi socialmente, culturalmente e geograficamente variabile. Gli standard di vita sono sicuramente più elevati, dunque, i consumi sono più alti e, di conseguenza, lo è anche il loro impatto ecologico. Anche qui, però, sarebbe utile porsi un quesito: parte del disastro ecologico è attribuibile alla classe media mondiale soltanto perchè ha più comodo accesso ai servizi di base e ad alcune di quelle comodità invece negate alle classi più povere? E cosa dovrebbe fare la classe media per non essere accusata di questo? Magari rinunciarvi stoicamente, sprofondando in una galassia di “ultimi” già ben nutrita?
Non resta quindi che ragionare sull’ultima fascia di popolazione ossia quella dei ricchi. L’esistenza di persone (poche) in grado non soltanto di accedere ai servizi essenziali ma anche di concedersi comodità e lusso a piacimento, quando altre persone (moltissime) non hanno neanche accesso all’acqua potabile, ci fa già schiumare di rabbia. Ed è proprio la produzione di questi sentimenti che dovremmo il più possibile evitare quando si ragiona su argomenti specifici come questo. Un approccio lucido ci permette di analizzare il fenomeno senza scadere in un inutile, quanto deleterio, moralismo.
È senz’altro uno schiaffo in faccia alla povertà godere di inutili lussi quando c’è chi muore di fame, per di più quando l’impatto ambientale di quei lussi quasi sicuramente andrà ad incidere sulle vite martoriate di quegli stessi che già hanno difficoltà a reperire qualcosa da mangiare. Il ricco, da questa prospettiva, è il più immorale di tutti. E poco importa che si dedichi alla beneficienza e alla filantropia, mostrando anche sincero interesse per il flagello della povertà o per la giustizia climatica. In questo modo esso non fa che ridare indietro una misera parte di ciò che ha sottratto alla società.
Ma è proprio la società, non il ricco, il povero o il benestante, che deve finire sotto la nostra lente d’ingrandimento. Analizzare il comportamento dei singoli è una strada senza uscita se non si considera il modello politico-economico che l’ha prodotto. Non deve interessarci il livello di consumo del ricco in sé, bensì l’assetto produttivo che genera il ricco e, a cascata, il benestante e il povero. Non deve interessarci chi possiede dieci fuoriserie in garage; piuttosto, la nostra attenzione deve focalizzarsi su quel modello produttivo che, per dare alla luce un bene non certo indispensabile come una fuoriserie, sfrutta senza scrupoli manodopera a basso costo e depaupera le risorse naturali di quei paesi da cui, spesso, quella stessa manodopera a basso costo proviene. In definitiva, deve interessarci il capitalismo e l’apocalisse sociale ed ecologica che sta generando. Il resto è mera perdita di tempo intellettuale.